“L’amore casomai”, di Rita Pacilio, letto da Gavino Angius
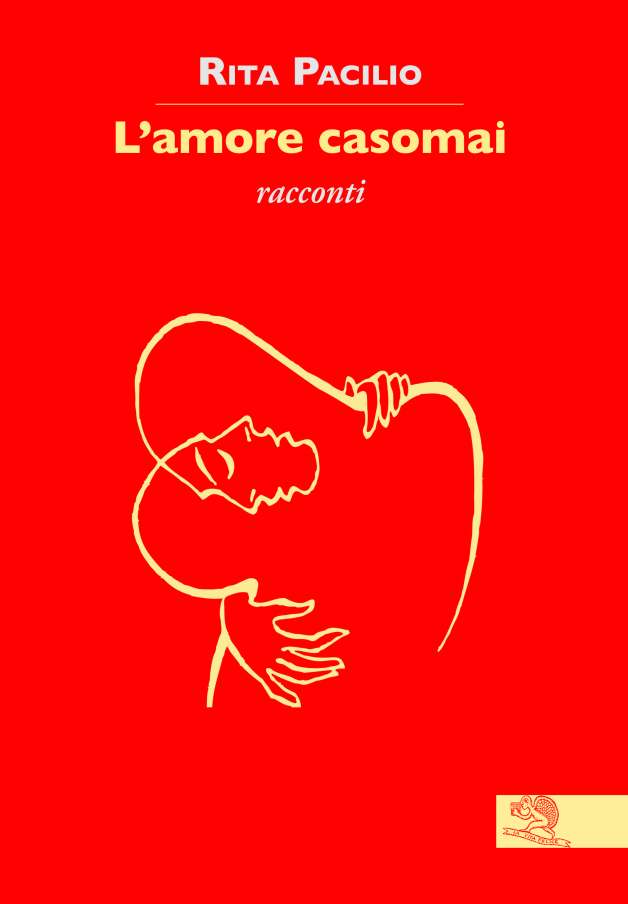
Facciamone una questione di genere. Genere letterario, ovviamente. Ebbene sì, questi sono racconti, come preannuncia il sottotitolo in copertina, porgendo la mano al lettore per stipulare il noto patto. Ed è un’indicazione verniciata di sana improntitudine, solo un pelino meno, poniamo, di quella messa in campo da Jamie Iredell che, qualche anno fa, osò intitolare un certo suo volumetto, oggi di culto: Prose. Poems. A Novel.
Multiformi e inafferrabili, sono una famiglia differenziata di ardua collocazione tassonomica. Manovre d’avvicinamento, ibridazioni. Poemetti in prosa che si dilatano in versi sapientemente cadenzati per poi avvitarsi in sentenze e aforismi, aneddoti e dialoghi, non rinunciando alle tentazioni − e perché no? del botta-e-risposta rubato agli sms. Con un disegno d’insieme che ammicca al racconto in versi, o quasi versi, al prosimetro, all’epos. Sempre che i componimenti raccolti nell’Amore casomai (Milano, La Vita Felice, 2018) di Rita Pacilio siano singoli, e non tappe o stazioni di un flusso, di un continuo, di un’opera unica.
Non facciamo alcun torto all’opera e all’autrice, se alterniamo lo sguardo d’insieme alla lettura microscopica. È il libro che lo suggerisce, talvolta lo impone. Più che frammentato, il testo è a segmenti, uniti da snodi flessibili e in apparenza precari, ma solidissimi, che assicurano la tenuta d’insieme, il polso della composizione varia, che si scioglie e rallenta, precipita, trova una sua regola. L’effetto d’insieme è garantito, e allo stesso tempo violato continuamente, da un tema, e da un intento musicale, dubitativo e aperto come vuole il titolo. La sequenza di racconti si ordisce in una storia, scandita in rapsodia ribelle di recitativi e arie. Riesumeremmo volentieri il desueto “cassazione”, se non ci avesse già pensato suo tempo Raboni, declinata però in forma non citazionista, a differenza di Raboni, ma, in largo compenso, con un intento e un piglio avventuroso. Intermittenze del respiro, prove di soffocazione, quelle che rendono supremamente e inesorabilmente lucido, non maculate dall’istinto di sopravvivenza.
Insomma, il libro è un intero, ha una sua vocazione al continuum, sorretto com’è da un basso ostinato sul quale s’innestano lacerti di storie, a punteggiare ritmicamente il tessuto d’una stoffa immaginativo-sonora. Un bildungsroman scomposto in fattori primi, se si vuole, come può essere concepito nel post-novecento
“Si sdraiò scomposto sul letto.” Reclama attenzione, quest’incipit cadenzato, marcato da allitterazioni. S’incomincia con un’azione, come in un romanzo d’azione, anche se l’azione qui è in apparenza rinunciataria e approssimativa, tende all’iperbole inversa. E già si preannunciano incastri e bilanciamenti fra agire e patire, perché, in certe situazioni, ben sappiamo che esse est pati. S’invocano azione e passione, una voce che scaldi, e che cosa meglio della voce può veicolare in successive prospezioni racconto-romanzo-autobiografia (quell’autobiografia degli altri che è impossibile voler vivere, come rammenta un memorabile verso di Mei-Mei Berssenbruge). Cadenza, inno al linguaggio sulla portante del linguaggio. Ci sembra di veder affiorare come annegati dallo schermo d’un’acqua non troppo tersa, i lineamenti dei due agonisti, non vogliamo ancora chiamarli protagonisti. Anche perché l’identità delle figure che animano il libro, se la volessimo ravvisare, si sfalda e ricompone continuamente, con l’effetto di precarietà della sabbia che smotta sulla pendice delle dune o del volteggio d’una gonna a pannelli. E di ciascuna si potrebbe dire, come del personaggio-persona di Luna crescente: “Non sa giocare. Non ha mai imparato.” Dopo, non c’è alibi, nel senso dell’etimo: dove altro essere in quel momento dato, dove essere andati, dove altro stare.
Saranno prodigi dell’angelo che fa la sua comparsa, forse fin troppo terrestre, o sortilegi gettati dalla vecchina, fata, strega, sibilla, esseri perturbanti, deputati a emettere benedizioni e profezie, a disseminare enigmi? Presenze liminari. Di quelle figure liminari seguiamo le evoluzioni, dal carnale al filosofico. L’escursione delle atmosfere costeggia quella dei registri di stile e di lingua, sempre sorvegliatissima, e basterà soffermarsi sulla prima composizione per essere trascinati da un’onirica mezza luna, avvolti dal fiabesco d’un’abitazione fatta d’alberi, approdare al colloquiale dei pannelli solari gettati su tralicci, al cronachistico “quella non è stata l’ultima volta”, all’eros − tentato dall’ironia − del seno “scoperto in addestramento”.
L’emblematica dell’amore-casomai (dove pesano sui piatti opposti della bilancia il caso e il mai) sa condensarsi e scaricarsi tutta in un punto: “Hai un anello messo di traverso”, balenante immagine di precarietà e di frettolosa conclusione, o assenza di conclusione. È capace di mettersi in scena con elementi fuori dalle convenzioni: tre attori, un messaggio telefonico replicato a cascata, i cerimoniali del voyeurismo e del bondage − (occorre dirlo?) verbali ed ecfrastici – e la scansione dei tempi – anch’essi verbali − che riporta a un quotidiano quasi più minaccioso del sesso estremo, una doccia e i figli che ritornano da scuola. Il corpo dell’anatomia proiettato sghembo sul corpo dell’esistenza, dicibile e cieco, ovvio che non combacino i loro contorni. Trova pretesti, con didascalie per un dialogo impossibile, forzato, parole che vengono agitate come oggetti minacciosi, piegamenti d’ossa, urla compresse, e maschere e paraventi. In fondo, la presenza femminile che si profila, si vorrebbe “come una donna sana”. Sana, pronta a scaricare sull’innocente ignoranza verso i fatti del sesso, l’ignoranza madre della scoperta, amara o trionfale. O ancora, questa capziosa emblematica, con una variazione che è animazione, allestisce un tripudio d’oggetti quotidiani chiamati come comparse in un film: sarà casuale il brand name della nutella con l’iniziale minuscola che defrauda e forse irride tanto brand naming?
Il cerchio si chiude. Nell’incipit si invoca una voce, nel finale la voce proviene già fuori dalle quinte: “Un tavolo per due. Io non c’ero.” In mezzo, l’irrimediabile. Elisioni, cenni, tagli sapienti, anticipazioni, frenate brusche e sbandamenti. E la schermaglia spiazzante di deittici e pronomi – così necessari alla narratività, così proclivi a farsi gioco di specchi e trompe-l’oeil. Avviene perfino che il prosimetro si replichi en abîme nei singoli componimenti, mentre, in un contropiede assassino, verso e prosa rovesciano i fronti e si scambiano di ruolo. Così come si rovesciano il dentro e il fuori, il necessario e l’accessorio: “Si allontanò dal corpo e lo spinse verso l’uscita.” Gli strappi, le eresie, creano inediti effetti di senso con il tempismo perfetto di un’approssimazione sempre differita del dicibile. La frattura lascia trapelare un sé. Perché “Le fantasie a volte sono circostanze”, che abbiano come sfondo un ambiente silvestre o claustrofiliaco. Sono rappresentazioni educatamente oltraggiose, adorne di colori tanto freschi che quasi sbavano, successioni d’immagini, trasformismi allusivi, e i sedimenti che lasciano, finissimi, quintessenziali, sono la parte che rimanda all’intero e lo denuda.
Carico esistenziale spinto sull’orlo del precipizio di chissà quale avvento, ordinata da una sintassi corpuscolare che disloca e ricolloca blocchi, a volte con frenesia visionaria, questa nuova opera di Rita Pacilio. Più audace del precedente Prima di andare, che recava una modesta – solo quantitativamente, ma tutt’altro che timida – presenza, accanto ai versi, di prose in forma epistolare, e attestazione d’un itinerario perseguito con fedeltà alle scelte. Rubo altre immagini in azione dal Gatto, una delle prose più compatte, che si rapprendono in concrezioni sonore, generano rimandi, ecolalìe: “Dalla bocca viene fuori la prima voce.” “Le spiegò il significato del godimento la lingua veloce.” “Mescolarsi al tempo.” “Lei la febbre di notte. L’abbracciava stretto quando il bisogno di nutrirsi. Leccava al grappolo carnoso mentre il gatto spia e tace.”
Stile è anche dispositio, architettura, decontestualizzare e ricontestualizzare, scelta di spazio e di tempo, semantizzare per l’occhio della mente che testimonia, come qui l’enigmatico ed eponimo gatto. Quale che sia l’albero genealogico di questo L’amore casomai, ciascuno risponde per sé, la responsabilità è individuale, anche nell’assumere, trasformare o rigettare una tradizione, non diciamo fondarne una ex novo. Ci s’individua per genere e differenza, anche in poesia. In ogni opera di poesia che voglia dirsi riuscita, si riacutizza il vecchio tormento: accordare in giusta tensione senso e suono, secondo l’accezione più ampia che risulta in forma e s’impone, così alla rosa come al cammello, con buona pace di tutti, perfino dei ‘contenutisti sartriani di ritorno’, e neo-contenutisti. Nell’acquietarsi di Telemaco nel sonno, che chiude il primo libro dell’Odissea, nella metafisica del sapone di Ponge, nell’anonimo lui di Rita Pacilio, per il quale “… la storia aveva deciso il giorno di rendere giustizia all’apparenza perché la sparizione avesse dimora nel maglione a coste larghe”, la poesia condensa una vocazione all’esemplarità, al mito di fondazione, all’una volta per tutte.
Gavino Angius
Questa via che porta
Le devi dare un nome.
Un’intensità privata come la cosa che guardi nelle tempeste.
Se fossi stata lei sarei sparita, non avrebbe avuto importanza
la domanda alle due di notte. Se fossi stata lei avrei avuto
decenza
capito il momento buono per smettere il gioco delle parti.
L’immagine di me l’unico piatto della bilancia.
Lo sapevi?
Se fossi stata lei avrei morso l’erba, avrei pianto come unico
animale della terra. Avrei rallentato il passo dell’addio.
Sarei stata zitta dietro le quinte. Avrei tolto il saluto agli sconosciuti,
baciato il Cristo che amava.
Invece sono io. Sono io. La penitenza della tara.
Un’intensità privata come la cosa che guardi nelle tempeste.
Se fossi stata lei sarei sparita, non avrebbe avuto importanza
la domanda alle due di notte. Se fossi stata lei avrei avuto
decenza
capito il momento buono per smettere il gioco delle parti.
L’immagine di me l’unico piatto della bilancia.
Lo sapevi?
Se fossi stata lei avrei morso l’erba, avrei pianto come unico
animale della terra. Avrei rallentato il passo dell’addio.
Sarei stata zitta dietro le quinte. Avrei tolto il saluto agli sconosciuti,
baciato il Cristo che amava.
Invece sono io. Sono io. La penitenza della tara.
Rita Pacilio (Benevento 1963) è poeta, scrittrice, collaboratrice editoriale, sociologa, mediatrice familiare, si occupa di poesia, di critica letteraria, di metateatro, di letteratura per l’infanzia e di vocal jazz. Curatrice di lavori antologici, editing, lettura/valutazione testi poetici e brevi saggi, dirige per La Vita Felice la sezione ‘Opera prima’. Direttrice del marchio Editoriale RPlibri è Presidente dell’Associazione Arte e Saperi. Ha ideato e coordina il Festival della Poesia nella Cortesia di San Giorgio del Sannio. Sue recenti pubblicazioni di poesia: Gli imperfetti sono gente bizzarra (La Vita Felice 2012) traduzione in francese Les imparfaits sont des gens bizarres, (L’Harmattan, 2016, Traduction en français par Giovanni Dotoli et Françoise Lenoir) e per Uet Tunisi la traduzione in lingua araba (a cura del Prof. Othman Ben Taleb); Quel grido raggrumato (La Vita Felice 2014); Il suono per obbedienza – poesie sul jazz (Marco Saya Edizioni 2015); Prima di andare (La Vita Felice, 2016). Per la narrativa: Non camminare scalzo (Edilet Edilazio Letteraria 2011). La principessa con i baffi (Scuderi Edizioni 2015) è la sua fiaba per bambini. È stata tradotta in greco, in romeno, in francese, in arabo, in inglese, in spagnolo, in catalano, in napoletano. A marzo 2018, per La Vita Felice Edizioni, Milano, la pubblicazione dei racconti in prosa poetica: L’amore casomai.

Nessun commento:
Posta un commento